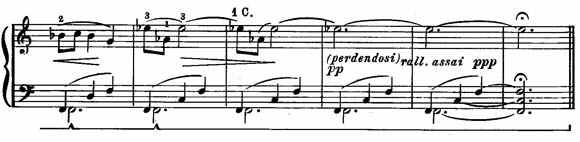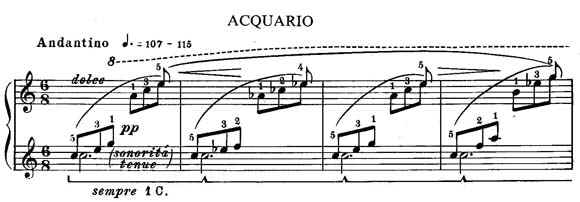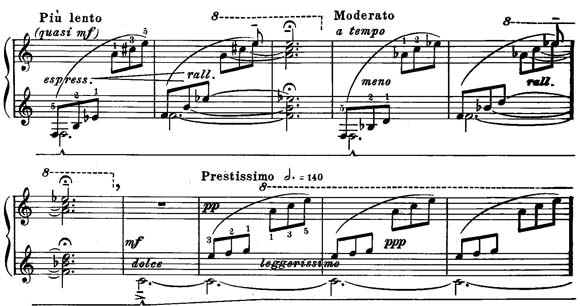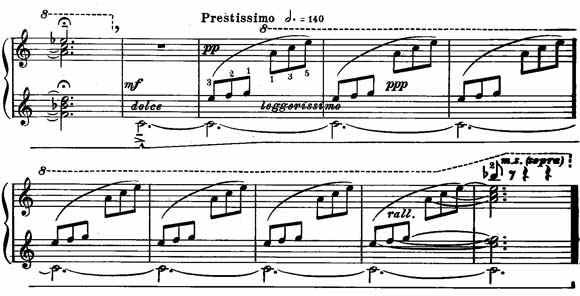Patrizia Valente
Il Quaderno Pianistico di Renzo Op.7:
Aspetti metodologico-didattici
di un'opera del Novecento musicale italiano
3. IL QUADERNO PIANISTICO DI RENZO OP. 7
3.4. Selezione di brani per la classe II
Nel “Quaderno Pianistico di Renzo op. 7” il compositore italo-argentino
utilizza reminiscenze dello stile romantico e post-romantico mediante un linguaggio
assolutamente contemporaneo e fortemente comunicativo. Infatti anche nel Valzer,
nella Barcarola e nell’Acquario (brani che possono essere inseriti
nella programmazione della classe II) egli sfrutta al meglio le risorse dinamiche e
coloristiche dello strumento riallacciandosi alla tradizione pianistica che fa capo a
Rachmaninof e Prokof’ev, di cui sviluppa ulteriormente l’efficacia della
scrittura e la varietà timbrica. Calligaris fa rivivere lo spirito degli autori
rivisitati con la sua originale poetica che, attraverso i contrasti espressivi, ricorre ad
atmosfere dilatate ed incantate.
Nel Valzer è evidente l’uso esclusivo dei tasti neri nella linea melodica
assegnata alla mano destra (Fig. 1); ciò può essere sicuramente utile per sviluppare la
tecnica d’aggancio di quei tasti che spesso risultano più scomodi da suonare.
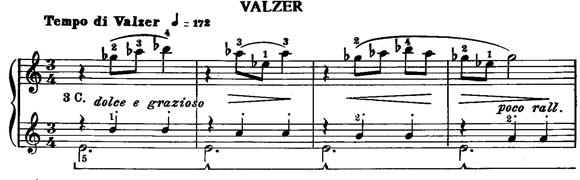
Figura 1. Primo rigo del Valzer
Non possiamo dimenticare altresì che queste note devono essere eseguite secondo
l’indicazione metronomica consigliata dall’autore, che è di 172 la semiminima
(Fig. 1). Così l’allievo avrà l’opportunità di potenziare l’agilità
delle dita, mantenendo una corretta posizione della mano e riuscendo pertanto a
raggiungere quella disinvoltura tecnica indispensabile per dare poi attenzione alla
dinamica.
La mano sinistra, a cui è affidata un’esecuzione da realizzare solo sui tasti
bianchi, sarà invece impegnata ad affrontare un altro problema tecnico, quello che vede
una nota tenuta lunga, mentre altre dita della stessa mano sono occupate ad eseguire altri
suoni diversi fra loro (Fig. 1). Questo passaggio tecnico è stato già rilevato nel Preludio,
ma quello che troviamo nel Valzer propone, a differenza del primo, l’impiego
di note “staccate” sovrapposte al suono tenuto. Certamente l’allievo dovrà
esercitarsi al raggiungimento dell’indipendenza delle dita, focalizzando la modalità
giusta per eseguire lo “staccato” con leggerezza e precisione.
Troviamo anche nella parte centrale della composizione, all’interno di una
successione di crome, la presenza di due note uguali di cui una “ribattuta"(1)
con cambio di dito” (Fig. 2). Queste saranno eseguite dalla mano destra, com’è
indicato dalla diteggiatura scritta, attraverso uno scambio che avviene dal dito medio al
dito pollice.

Figura 2. Terzo rigo del Valzer
Sarà l’occasione giusta per approfondire la regola inerente ad un delicato
movimento che comporta la necessaria stabilità della mano sulla tastiera e la
realizzazione di uno spostamento contenuto ma elastico. Si potrà così ottenere quel
particolare “legato” utile alla produzione di due suoni simili nella loro
intensità.
Secondo Leschetizky, la nota “ribattuta”(1) deve essere eseguita solo
dall’articolazione del dito, con polso e mano fermi. Le dita dovranno resistere
all’impatto col tasto e scivolarvi sopra, mentre il polso dovrà essere tenuto libero
ed alto, in modo da consentire una leggera rotazione della mano e aiutare così le dita
nel loro movimento.
 Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del
pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del
pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il
pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale
cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.
Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del
pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del
pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il
pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale
cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.
La presenza delle pause di semiminima, nei primi due righi del brano, permetterà allo
studente di applicare la regola teorica inerente alle figurazioni e di esprimere meglio
l’andamento ternario caratteristico del valzer (Fig. 1). Alla mano sinistra è
affidata invece una sequenza di crome (Fig. 2), per la durata di otto battute, che vengono
eseguite solo e costantemente dal dito medio e dal dito pollice; alternandosi realizzano
l’intervallo di terza che, scendendo di grado congiunto all’inizio di ogni
battuta, consentirà all’allievo di eseguire un’articolazione contenuta delle
dita, necessaria per evitare la perdita di controllo della tastiera in velocità.
Nella penultima e terzultima battuta del brano sono presenti alcune note staccate che
saranno eseguite dalla mano sinistra mediante la tecnica dello “staccato di
polso” (Fig. 4): le dita si alzeranno insieme al polso, dopo che hanno percosso il
tasto dall’alto. Questo movimento sarà necessario a creare delle sonorità più
morbide e delicate, e ad eseguire il diminuendo con il tocco più adatto.
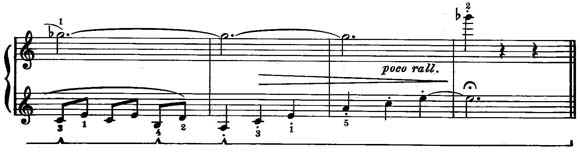
Figura 4. Finale del Valzer
Questo brano presenta un motivo melodico leggero, spensierato e gioioso, caratterizzato
da un certo sentimentalismo elegante. Lo studente sarà stimolato ad interpretare
l’idea musicale dell’autore seguendo le indicazioni dinamiche scritte. Egli
potrà ricreare quella atmosfera di colori luminosi e nitidi, e quella sonorità
“scintillante” (come precisa Calligaris nella nona battuta) che caratterizza lo
stile eloquente e raffinato del pensiero compositivo, attraverso l’espressione della
propria sensibilità musicale (Figura 5. Nona battuta del Valzer).
 Per ottenere il giusto
tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una
parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è
particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni
percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito
avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere
al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco
stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per
l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da
eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,
nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni
difficoltose.
Per ottenere il giusto
tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una
parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è
particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni
percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito
avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere
al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco
stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per
l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da
eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,
nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni
difficoltose.
La Barcarola (Allegretto cantabile) è un brano dal carattere riflessivo e
sognante. Le note presenti nelle prime quattro battute (Fig. 6), eseguite dalla mano
sinistra, ci anticipano un’atmosfera suggestiva e rilassante che rievoca il moto
lento ed ondulatorio di una barca.
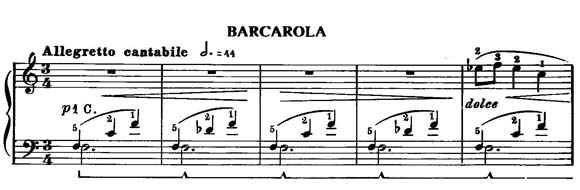
Figura 6. Primo rigo della Barcarola
In questo pezzo incontriamo i procedimenti tecnici comuni a quelli dei brani esaminati
in precedenza, eccetto il “passaggio del pollice sotto la mano” qui presente,
assegnato alla mano destra (Figura 7. Nona battuta della Barcarola).
 Voglio specificare
che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica
pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende
tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la
flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano
orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve
essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in
posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo
studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma
importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere
l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.
Voglio specificare
che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica
pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende
tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la
flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano
orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve
essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in
posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo
studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma
importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere
l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.
L’interpretazione di questo brano richiederà, da parte dell’esecutore, la
capacità d’immaginazione e la concentrazione necessaria a creare l’effetto
desiderato dall’autore. Sarà sicuramente gratificante per il discente riuscire a
comunicare all’ascoltatore l’idea compositiva insieme alle proprie sensazioni.

Figura 8. Quarto rigo della Barcarola
Basti osservare come nel quarto rigo (Fig. 8), dopo una continua alternanza del
“crescendo” e del “diminuendo” all’interno di una melodia dolce e
dal moto ondoso, emerge un “mezzoforte” espressivo, quasi a voler simulare il
movimento in ascesa di un’onda più alta, che subito si abbassa (p) per poi svanire
nel nulla.
Questo ultimo effetto si potrà ottenere solo eseguendo le indicazioni, suggerite
dall’autore nelle ultime tre battute, del “perdendosi”, del
“rallentando assai” e del “pianissimo” (ppp), (Fig. 9).
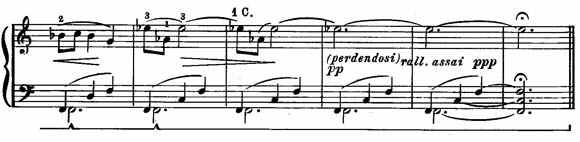
Figura 9. Quinto rigo della Barcarola
L’Acquario presenta invece una melodia eterea, suggestiva e rilassante,
ricca di delicate gradazioni timbriche. Calligaris predilige l’uso degli arpeggi,
insieme all’utilizzo dei pedali del “piano” e di “risonanza”, per
simulare il movimento di un’immagine reale la cui visione trasmette sensazioni di
piacevole leggerezza (Fig. 10).
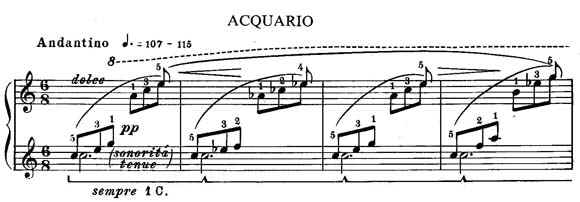
Figura 10. Primo rigo dell'Acquario
Il movimento agile delle due mani, che si alternano per l’esecuzione degli arpeggi
ascendenti (nelle prime sedici battute), e discendenti (nelle successive otto), dovrà
essere realizzato mantenendo le dita pronte sui rispettivi tasti e creando un lieve
movimento oscillatorio del polso che dovrà rimanere sempre elastico.
Il suono tenuto lungo (nella prima parte dalla mano sinistra e nella seconda da quella
destra), per la durata d’ogni battuta, sarà utile a mantenere il punto
d’appoggio necessario alla stabilità della mano sinistra e ad evidenziare
misuratamente il suono in battere (Fig. 10).
Nella prima parte del brano, l’autore raffigura l’ultima croma d’ogni
misura con la gambetta posizionata verso su affinché si distingua dalle altre per il suo
significato più espressivo (Fig. 10). L’allievo potrà eseguire questa figura con il
dito mignolo teso e vicino il tasto, per produrre un suono delicato ma cristallino.
Nell’ottavo rigo troviamo un arpeggio, in cui ogni nota sarà tenuta lunga dopo la
sua esecuzione, che andrà a sfociare in un accordo (Fig. 11).
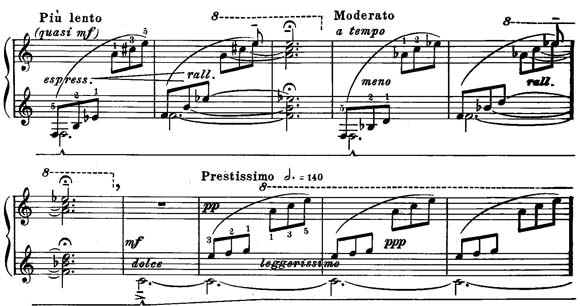
Figura 11. Ottavo e nono rigo dell'Acquario
Questo passaggio tecnico richiederà un giusto controllo del peso d’ogni dito, che
servirà all’allievo per ottenere delle sonorità dolcissime.
Il brano in esame potrebbe essere un esempio di musica descrittiva, per il quale
l’autore sceglie come fonte d’ispirazione il mondo acquatico, visto attraverso
il vetro di un acquario. Lo studente potrà sviluppare la propria capacità di
immaginazione e di fantasia ricreando l’atmosfera impalpabile e leggera, desiderata
dal compositore nell’esecuzione di questo brano. Egli potrà trasmettere
all’ascoltatore quelle sensazioni di calma, silenzio e benessere che si provano
osservando un acquario dall’esterno. In esso tutto si muove all’unisono,
seguendo un ritmo scandito dai lenti movimenti dei pesci. Le alghe ondeggiano
piacevolmente ed a tratti si avvolgono e si svolgono attorno alle rocce; coralli azzurri,
rossi o bianchi vestono il fondale e piccoli paguri fanno capolino.
I cambiamenti di tempo (Più lento – Moderato – Prestissimo), che troviamo nella
parte finale del brano (Fig. 11), saranno utili per simulare i movimenti dell’acqua
che sfugge dalle nostre dita, assume mille forme e si modella nello spazio.
La cascata d’arpeggi (Fig. 12), che è presente nella coda finale, verrà eseguita
molto rapidamente ed andrà a sfociare con la sonorità del “pianissimo” in un
accordo lungo.
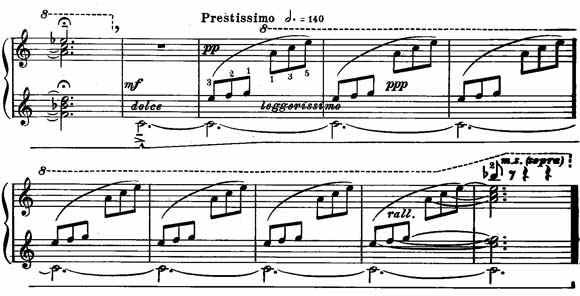
Figura 12. Nono e decimo rigo dell'Acquario
L’autore vi sovrappone l’ultima nota, il “si bemolle”, che sarà
raggiunta dalla mano sinistra scavalcando quella destra mediante il movimento morbido del
polso.
NOTE:
(1) MALWINE BRÉE, The Leschetizky Method. A Guide to Fine and Correct Piano Playing,
Mineola, New York, Dover Publications, 1997, p. 22.



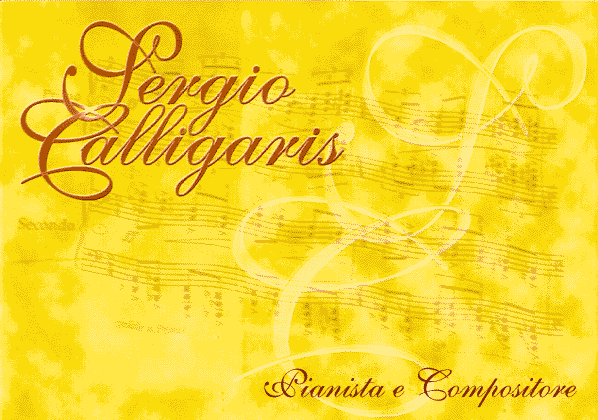
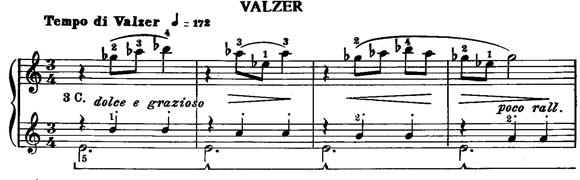

 Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del
pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del
pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il
pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale
cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.
Sarà affrontato dalla mano destra anche il “passaggio del
pollice” (Figura 3. La mano di Theodor Leschetizky che esegue il passaggio del
pollice), più precisamente il movimento della mano che passa “sopra il
pollice”, durante il quale l’avambraccio non dovrà seguire l’eventuale
cambiamento d’angolazione del muscolo palmare.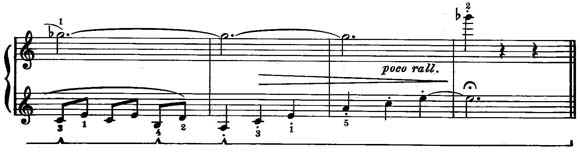
 Per ottenere il giusto
tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una
parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è
particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni
percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito
avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere
al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco
stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per
l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da
eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,
nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni
difficoltose.
Per ottenere il giusto
tocco bisogna porre molta attenzione alle punte delle dita, sapendo che vi è proprio una
parte precisa del polpastrello in cui la sensibilità delle terminazioni nervose è
particolarmente intensa. Con un po’ di pratica e attento ascolto delle sensazioni
percepite, si potrà trovare con assoluta precisione questo punto sul quale il dito
avvertirà la massima sensibilità dell’appoggio. Questo ultimo poi, deve permettere
al dito di sentire bene il martelletto e quindi di determinare con precisione il tocco
stesso. L’allievo, quando avrà trovato la posizione corretta della mano per
l’appoggio, potrà inclinare le dita secondo le necessità che il passaggio da
eseguire richiede. Egli terrà sempre come riferimento il punto di maggiore sensibilità,
nel caso in cui la mano dovesse percepire dei risentimenti a causa di posizioni
difficoltose.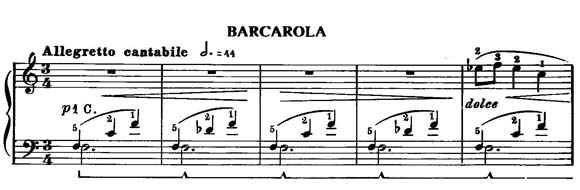
 Voglio specificare
che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica
pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende
tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la
flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano
orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve
essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in
posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo
studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma
importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere
l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.
Voglio specificare
che l’azione di questo dito svolge una parte molto importante nella tecnica
pianistica, in quanto la sua articolazione effettuata in modo corretto e libero, rende
tutta la mano più rilassata e sciolta. Il normale movimento del pollice avviene con la
flessione ed estensione dell’articolazione carpo-metacarpale, (movimento sul piano
orizzontale). Questa azione permette il passaggio del pollice sotto la mano, ma deve
essere seguita, per abbassare il tasto, da un movimento verticale che, con il dito in
posizione flessa (sotto il palmo della mano), non è di semplice realizzazione. Lo
studente potrà così affrontare con adeguata attenzione questo delicato ma
importantissimo problema tecnico; una volta superato gli permetterà di raggiungere
l’agilità delle dita e l’uguaglianza dei suoni prodotti.